IN UN POST DI QUALCHE ANNO FA AVEVO CERCATO DI CAPIRE COME NEL VOSTRO MONDO LA “VERITÀ” SI PUÒ DISTINGUERE DALLA MENZOGNA. E COME SI POSSONO SMASCHERARE LE DISTORSIONI VOLONTARIE DELLA REALTÀ, CUI CI HANNO ABITUATO LE FAKE NEWS, E I TANTI IMBROGLIONI CHE FALSIFICANO I FATTI PER FARE I LORO INTERESSI.
I miei superiori alieni, frastornati dalle tante verità che scienziati e politici terrestri sbandierano, venendo subito smentiti da altre “verità”, mi chiedono di tornare sull’argomento. Ma dal punto di vista delle diverse verità possibili su uno stesso fatto, e dell’uso che se ne può fare per sostenere le proprie convinzioni. Senza alterare i dati della realtà (come nelle fake news), ma presentandoli in modo tale da dimostrare la verità solo delle proprie ipotesi.

La storia del pianeta, sin dai primordi, ricorda innumerevoli personaggi ed eventi su cui sono state costruite verità storiche contrastanti. Su Nefertiti, Cleopatra, Augusto, Carlomagno, Colombo, Richelieu, Churchill, Mao e tanti altri, quale è la verità “oggettiva” se i fatti su cui ogni storico si basa per la valutazione sono veri, ma parziali?
La scienza – e la divulgazione scientifica – sono piene di teorie diverse, tutte con prove a favore o contro, che sono evidenti per chi sostiene l’una o l’altra ipotesi.
Nelle aule giudiziarie avvocati e periti propongono “verità” diverse sugli stessi fatti. E i giudici devono districare questo groviglio di verità, trovandosi spesso nella stessa posizione di Ponzio Pilato che durante il processo a Gesù si chiedeva “che cos’è la verità”. Ma i nostri giudici non se ne possono lavare le mani… E poi spesso il giudizio di appello ribalta la decisione, facendo prevalere un’altra verità, e lasciando tutti perplessi e sconcertati.
In medicina si propongono farmaci o interventi per alcuni miracolosi, per altri inutili, e per le entrambe le opzioni ci sono prove di ricerca a favore (e ovviamente, altrettante contrarie).
In psicologia le teorie sullo sviluppo umano e sulle relazioni sociali, e sulla stessa conoscenza, portano a conclusioni differenti, tutte ben supportate sul piano teorico e anche sperimentale. Però partendo da metodologie diverse si arriva a conclusioni differenti, ognuna plausibile.
Come districarsi fra tante “verità” spesso contrapposte? Lasciando il giudizio ai “dati”, spesso tradotti in numeri? Ma i numeri quando riguardano argomenti complessi, sfaccettati e in continuo cambiamento, aumentano la confusione anziché offrire un riparo dall’incertezza.
Le statistiche si possono interpretare come si vuole per confermare le proprie ipotesi. Così i dati sull’alimentazione, sulle risorse energetiche, sull’occupazione, possono essere letti e citati in modi diversi, e suggerire interventi addirittura opposti in base a quali interpretazioni vengono privilegiate. Ad esempio, se cresce il numero dei contratti di lavoro, ma solo per certe categorie e in certi ambiti, le politiche economiche e sociali funzionano o no?
In politica le statistiche rappresentano verità alle quali si possono contrapporre dati altrettanto veri.
Se – come è avvenuto nelle recenti elezioni europee – la metà dei potenziali votanti si astiene, le percentuali reali di consenso di ciascun partito andrebbero calcolate sui votanti effettivi. Quindi il 30% e il 24% ottenuti dai due primi partiti diventano rispettivamente 15% e 12%. Si passa da circa un quarto a poco più di uno su dieci.
Se un governo ha una maggioranza del 51% e proclama di agire in base al consenso della maggior parte dei cittadini, dice la “sua” verità. Perché intende “la maggior parte dei cittadini che votano” (ma omettendo l’ultimo pezzo). A questa verità si può opporre, con altrettanta veridicità, che solo un quarto di chi ha votato si è espresso per la maggioranza di governo, mentre gli altri tre quarti o hanno espresso il dissenso non votando, o si sono espressi a favore di altri. Altro che consenso maggioritario…
Dunque, pur senza alterare i dati della realtà, si hanno diverse “verità”.
È quanto sosteneva Pirandello nel suo “così è (se vi pare)”. Relativismo conoscitivo che già i greci antichi conoscevano bene, distinguendo la ἀλήθεια dalla δόξα, e che molti pensatori hanno ripreso e riaffermato. Certo, la separazione tra verità e apparenza a molti (e anche a noi alieni) sembra anti-scientifica, ma è inevitabile per quasi tutte le realtà umane che ci è dato di conoscere: storiche, sanitarie, giuridiche, politiche. Ma anche per le relazioni sociali, ad esempio i conflitti coniugali, o i rapporti di lavoro, o le liti condominiali. Tante di queste realtà sembrano “oggettive” se chi le presenta è bravo a convincere che non ci sono alternative, e chi ascolta non esercita il principio del dubbio. I bravi avvocati (e i propagandisti di mestiere) sono maestri in questo esercizio di costruzione di una realtà “vera”, cioè dimostrabile, che però non considera altri fatti contrastanti, anch’essi dimostrabili ma sapientemente occultati.

La realtà è una, ma è difficile conoscerla completamente e pienamente. Le verità sono tante, ognuno può costruirsi la sua e presentarla per l’unica realmente “vera”. Ignorando o evitando di riportare le prove di alternative diverse. E proclamando di “possedere” la verità e la certezza, da dispensare (e imporre?) agli altri: lettori di storia, utilizzatori di scoperte scientifiche, malati alla ricerca di cure valide, giurie che devono decidere in tribunale, o cittadini che dovrebbero votare. Eppure a questi bisognerebbe insegnare a cercare prove alternative a quella che sembra una verità, ma potrebbe non essere l’unica. E bisognerebbe cominciare a farlo fin dall’infanzia, abituandoli a cercare se ci sono alternative alle verità che i libri di storia o di scienze propongono. Magari avvalendosi, come qualcuno propone, di sistemi esperti basati sull’Intelligenza Artificiale, ma senza lasciare a questi supporti la decisione finale, che deve spettare sempre e soltanto alla responsabilità umana.
Essenziale è essere consapevoli di quanto diceva Popper: “Aspiriamo alla verità, ma raramente, o mai, possiamo essere del tutto certi di averla raggiunta”. Secondo Einstein “la ricerca della verità è più preziosa del suo possesso”.
Non la presunzione di avere certezze e propinarle al mondo, ma desiderare la verità, e cercarla, è ciò che qualifica come esseri ragionevoli e pienamente “umani”.


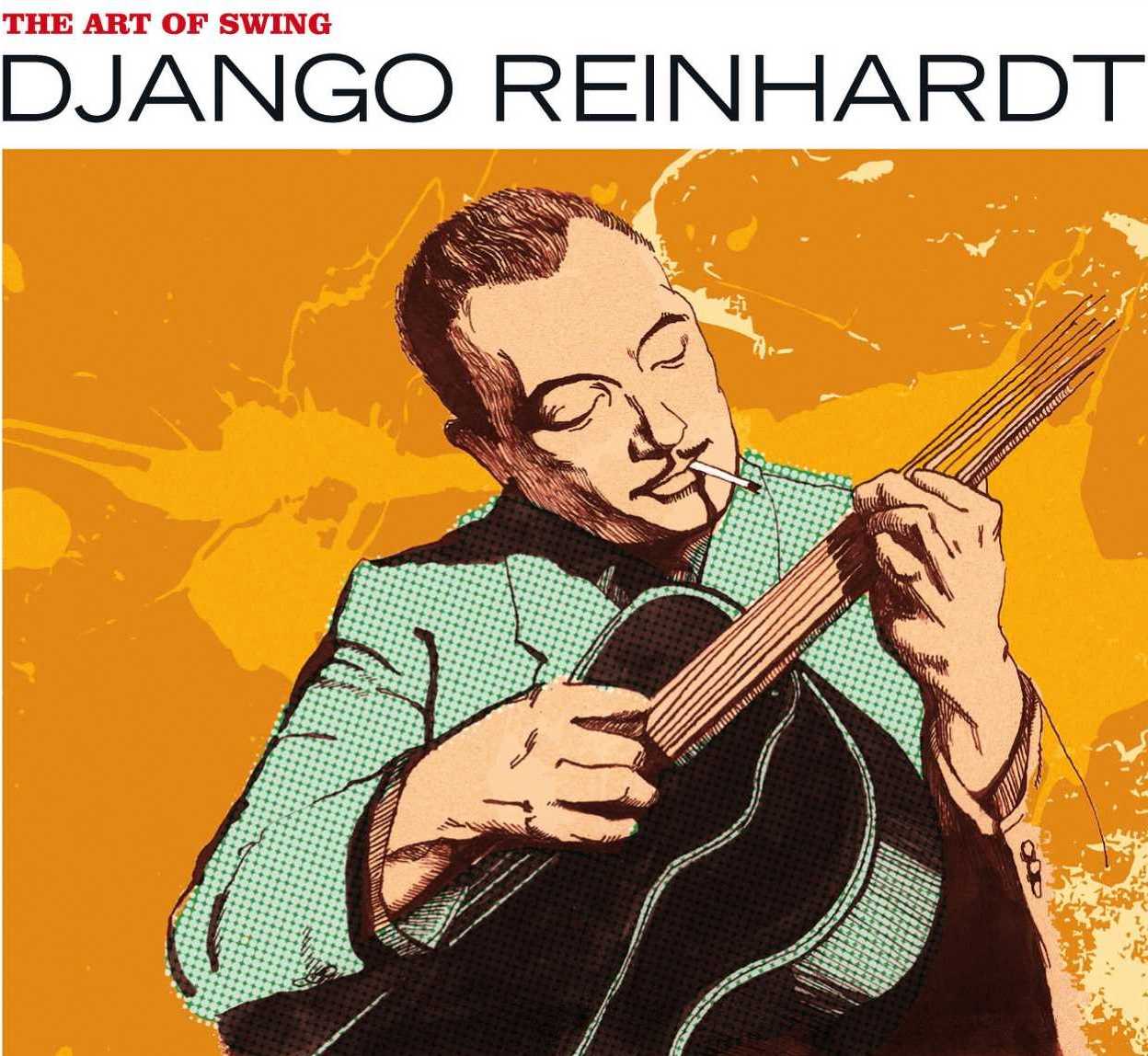
Comments are closed.